Il carrello è vuoto

Autismo e intervento psicoeducativo
Parlare di intervento psicoeducativo nella “cura” dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo richiede di riconoscere nell’espressione comportamentale dei sintomi, quello che un po’ provocatoriamente potrebbe essere definito il “pensiero autistico”. Grazie allo sviluppo della ricerca, oggi sappiamo che le persone che rientrano all’interno dello spettro autistico indipendentemente dal livello di sviluppo cognitivo, linguistico e affettivo presentano una specifica difficoltà nell’utilizzare “una teoria della mente” per comprendere il comportamento delle altre persone (SURIAN e FRITH, 1993): l’incapacità, in breve, di inferire una rappresentazione degli stati mentali propri e altrui.
Spesso queste persone possono avere una comprensione letterale della realtà, possono comprendere una rappresentazione basata soprattutto sui dati ottenuti attraverso l’atto percettivo, ma sono in difficoltà nel comprendere una rappresentazione più complessa per la quale sarebbe richiesta la comprensione del significato del comportamento di più persone in relazione tra loro.
Surian (2002) propone di riferirsi a questo disturbo con il termine di psicoagnosia, espressione che identifica in una parola la mancanza selettiva delle conoscenze sugli stati mentali come conseguenza di un disturbo specifico di accesso a questo tipo di conoscenze.
Le persone che rientrano nello spettro autistico possono presentare ancora deficit nelle funzioni esecutive e/o nei processi di codifica percettiva. Ozonoff e McEvoy (1994), Ozonoff e Jensen (1999) hanno rilevato un deficit selettivo nell’abilità di shifting, cioè nella capacità di spostare l’attenzione su proprietà dello stimolo diverse da quelle precedentemente considerate. Frith (1989) ritiene che nelle persone autistiche venga meno la “spinta” a integrare le informazioni in un tutto coerente e dotato di significato; lo stimolo non verrebbe perciò elaborato in riferimento al contesto di cui è parte e l’informazione ricavata rimarrebbe fine a se stessa. Questa difficoltà dipenderebbe da processi centrali di integrazione delle informazioni sensoriali e non tanto da un disturbo percettivo periferico.
La presenza di questi deficit cognitivi, a volte isolatamente, altre volte in modo combinato, può compromettere l’interazione sociale, la comunicazione e lo sviluppo emotivo: è del tutto intuibile quali problematiche si possono creare quando viene a mancare l’intersoggettività, l’intento comunicativo e la comprensione degli effetti prodotti dalla comunicazione sull’altro.
Le ricerche neuropsicologiche hanno, dunque, fornito un quadro di riferimento per la comprensione del funzionamento della mente delle persone autistiche permettendo di guardare ai sintomi come espressione delle limitazioni imposte dalle abilità cognitive possedute.
Temple Grandin, autistica, professoressa alla Colorado State University, nonostante abbia raggiunto una posizione di rilievo nella società, nel suo libro Pensare in immagini (1995; trad. it. 2001) ci fornisce una testimonianza delle quotidiane difficoltà che incontra nelle situazioni sociali: “...anche oggi, le relazioni personali sono qualcosa che non riesco a capire fino in fondo ... Io non so leggere i sottili indizi emozionali. Ho dovuto imparare per prove ed errori cosa significano certi gesti e certe espressioni facciali. All’inizio della mia carriera prendevo i primi contatti per telefono, il che mi era più facile perché non mi costringeva a gestire segnali sociali complessi” (p. 124, 126).
Per quanto riguarda le modalità di pensiero, l’autrice sottolinea come il suo non sia costituito da una successione di parole, ma da immagini che si susseguono in modo associativo l’una all’altra. Quando pensa a un campanile rivede tutti i campanili che ha visto nella sua esperienza; per arrivare a costruirsi un concetto deve ogni volta avviare un percorso che parte dallo specifico per arrivare al generale. Un pensiero come questo, che Temple Grandin (1995) definisce pensiero associativo in immagini, è un pensiero estremamente dispersivo perché i particolari di un’immagine possono attivarne un’altra connessa a quel particolare, costruendo catene infinite di associazioni con il rischio di perdere il filo del discorso. È quindi necessario riuscire a riprendere il controllo e ritornare al punto immagine dalla quale il pensiero era iniziato: “i miei ricordi generalmente mi affiorano alla mente in ordine rigorosamente cronologico e le immagini che visualizzo sono sempre specifiche” (p. 31).
Per l’autismo non esiste una cura, ma dove non c’è cura ci sono spesso innumerevoli trattamenti (COHEN e VOLKMAR, 1997). Il lavoro del clinico deve puntare a migliorare le difficoltà e ad acquisire nuove abilità e strategie utili a fronteggiare le diverse situazioni della vita. Per raggiungere questo obiettivo è prima di tutto indispensabile comprendere la peculiarità del funzionamento psicologico della persona con autismo e cercare di comprendere le modalità attraverso le quali si esprime.
È ormai consolidata l’opinione che l’intervento debba puntare a migliorare la qualità della vita insegnando alla persona autistica a fronteggiare le difficoltà che può incontrare nel proprio cammino.
L’intervento educativo deve perciò porsi domande su cosa e come insegnare, individuare cioè le aree in cui proporre l’apprendimento di nuove abilità, con particolare attenzione alle metodologie più appropriate per raggiungerle (MICHELI, 2003). Le recenti ricerche scientifiche hanno sottolineato sia i deficit sociali e sociocognitivi spesso presenti in queste persone (difficoltà nel condividere il significato dell’intento comunicativo e delle interazioni reciproche, con deficit nell’attenzione sociale condivisa, attaccamento sociale, condivisione della conoscenza, la capacità di alternarsi, proporre argomenti di conversazione), sia i punti di forza cognitivi, quali ad esempio interessi particolari, abilità nella memoria meccanica e nell’elaborazione visiva (SCHOPLER, 1997; SCHOPLER e MESIBOV, 1995).
Dalla ricerca scientifica ci giungono quindi spiegazioni in merito alle cause di certi comportamenti e deficit, e indicazioni utili per individuare strategie educative che utilizzano i punti di forza cognitivi di queste persone.
L’intervento educativo diventa così psicoeducativo, in quanto applica le conoscenze acquisite da ricerche nell’ambito della psicologica dello sviluppo, della neuropsicologia, della psicologia cognitiva (servendosi dell’approccio metodologico proprio di queste discipline), delle strategie proposte da orientamenti di tipo cognitivo-comportamentale, all’educazione della persona autistica con interventi che dovrebbero favorire l’acquisizione di strumenti compensativi. Tutto questo avrebbe lo scopo di favorire la comunicazione, l’interazione, l’immaginazione, l’adattamento al contesto di vita.
Poiché questi interventi psicoeducativi richiedono accorgimenti e misure che necessariamente sono diversi da persona a persona (è fondamentale in questo ambito l’approccio del caso singolo), rendendo quindi difficile il controllo “sperimentale” di tutte le variabili in gioco, sarebbe buona consuetudine che gli operatori, sia clinici che educatori, acquisissero la consuetudine di raccogliere dati osservativi dal loro lavoro per discuterne l’efficacia e correggere gli errori. Il presente contributo ha quindi lo scopo di suggerire una metodologia di lavoro con gli strumenti necessari a una validazione dell’intervento, in modo tale da renderlo “probabilmente efficace”.
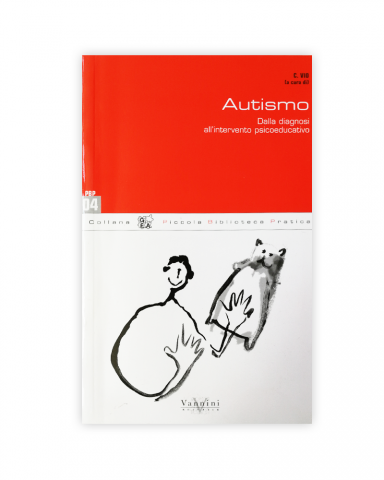
© Vannini Editoria Scientifica. Tutti i diritti riservati.
